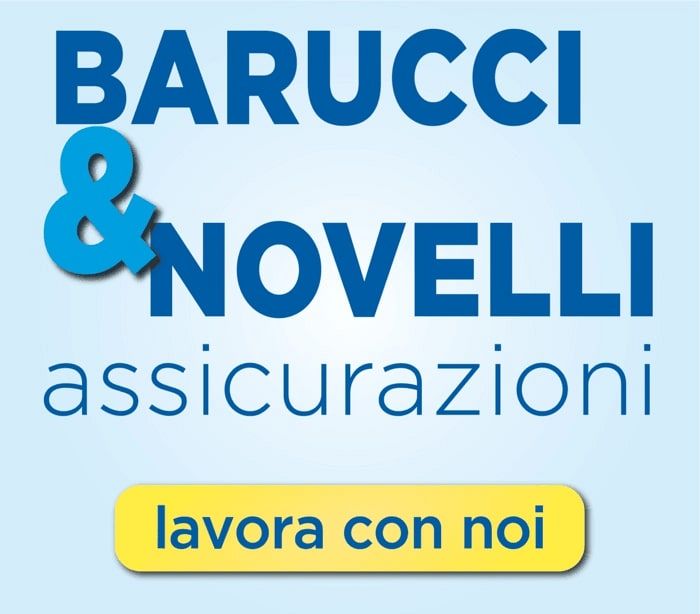Riceviamo e pubblichiamo un approfondimento di natura storica scritto da Antonino Zarcone.
1° luglio 1943, mancano pochi giorni alla caduta del Fascismo. Il Regime è in crisi, come hanno dimostrato gli scioperi del marzo precedente.
Anche dal punto di vista militare le cose per l’Italia vanno malissimo. Le truppe italiane sono state sconfitte definitivamente in Tunisia e gli Alleati hanno già avviato le operazioni per sbarcare sul continente europeo già decise alla Conferenza di Casablanca nel gennaio 1943.
Con l’operazione Corkscrew (in italiano: cavatappi) gli Alleati hanno già concluse le azioni preliminari volte , alla conquista dell'isola di Pantelleria e delle isole Pelagie, necessarie basi di partenza avanzate per il successivo sbarco in Sicilia; tra il 10 ed il 13 erano cadute Pantelleria, Lampedusa e Linosa.
Dopo questi primi sbarchi sul territorio italiano, era stato intensificato il movimento dei treni militari per il trasporto di rifornimenti e truppe verso il sud della penisola e verso la Sicilia, prossima tappa del comando Alleato per il Teatro Mediterraneo.
Per questo motivo erano aumentati anche i bombardamenti anglo americani sulle città italiane e sulla rete di comunicazioni della penisola.In questo primo giorno di luglio del 1943, alcuni vagoni di un treno militare, forse tedesco, si trovano abbandonati alla stazione di Castello.
Erano stati staccati probabilmente per la rottura dei ganci. E’ mattina presto quando in stazione giunge il direttissimo Venezia – Roma. L’impatto è tremendo. Secondo la cronaca di Giorvanni Devoto, trascritta in “Milano Davos 1942 – 1944. Diario di un dirigente industriale progressista”: Il locomotore si è inchiodato nel terreno, le tre vetture letto che lo seguivano lo hanno sorpassato e sono cadute. Parecchie vittime: alcune decine certamente”.
È questa una delle pochissime testimonianze dell’accaduto. La storia successiva per il territorio fiorentino sarà caratterizzata da maggiori tragedie: i bombardamenti, le persecuzioni razziali e le deportazioni, le stragi. Forse per queste ragioni la storiografia nostrana, purtroppo, non ha dato molto spazio alla “Strage ferroviaria di Castello”.
Forse anche il Regime ha contribuito a far calare l’oblio su quei fatti. Riporta lo stesso Devoto “Lo strano è che i giornali non hanno pubblicato nulla: tranne l’annuncio funebre di un console Barboglio perito nell’incidente ferroviario della notte del 1° luglio”.Ma quante furono le vittime. Soprattutto chi erano, anche perché questo da maggiori informazioni sull’accaduto. I morti furono portati tutti alle stanze mortuarie di via degli Alfani, per essere identificati e per essere sottoposti ad accertamenti medico legali.
Chi sono le vittime.
Il più noto è Francesco Barboglio, trentaseienne bresciano, funzionario del ministero degli affari esteri addetto all’ufficio trattati. Di lui scrive, nel proprio diario, Serafino Mazzolini, al tempo direttore generale poi ministro degli affari esteri nel periodo della repubblica sociale. Barboglio rientrava a Roma dopo aver partecipato a Venezia all’incontro tra il Conducator (ovvero Capo) e Primo Ministro rumeno Ion Antonescu ed il sottosegretario agli affari esteri italiano Giuseppe Bastianini.
Gli altri sono: Bencioli Delfo, 30 anni, coniugato, da Cecina (Li), Bani Ugo, 55 anni, coniugato, romano, Raparelli Giorgio, 22 anni,celibe, romano, Imbimbo Francesco, 43 anni, coniugato, romano, De Luca Antonio, di 29 anni, coniugato, di Roma, tutti impiegati delle poste e telecomunicazioni, Deli Carlo, 52 anni, coniugato, di Roma, commesso delle poste, Furia Antonio, 47 anni, coniugato romano, postino ferroviario, Castaldini Giorgio, 46 anni, coniugato, bolognese, capotecnico ferroviario, Castani Domenico, 31 anni, coniugato, di Cerignano (RO), dipendente delle ferrovie, Raimondi Amedeo, 48 anni, coniugato, di Roma, impiegato della compagnia dei vagoni letto.
La presenza di numerosi dipendenti delle poste e telecomunicazioni farebbe pensare alla presenza, oltre che dei vagoni letto, di uno scompartimento per il trasporto ferroviario della posta. A questi ci sono da aggiungere: Bolgia Giuseppe, 24 anni, di Gravedona (CO), aviere in servizio, che verosimilmente rientrava dalla licenza, Fasciani Dario, 21 anni, coniugato, abbruzzese, Bertoli Silvio, 24 anni, di San Luce (PI), celibe, boscaiolo. L’unico fiorentino è Leo Mazzanti, ventiduenne, coniugato.Nomi che non risulta che siano stati ricordati in una lapide. Vittime di un tragico incidente ferroviario e nel contempo vittime di guerra anch’esse. Dimenticati come tante delle vittime civili dell’ultimo conflitto mondiale.
Uomini sacrificati per una guerra che non avevano scelto di combattere e la cui Memoria dovrebbe far riflettere sulla guerra, totalitaria, che tutti può colpire indipendentemente dal ruolo esercitato nella società. Dopo tanti anni è doveroso volgere un pensiero alle vittime innocenti della strage dimenticata della stazione di Castello.