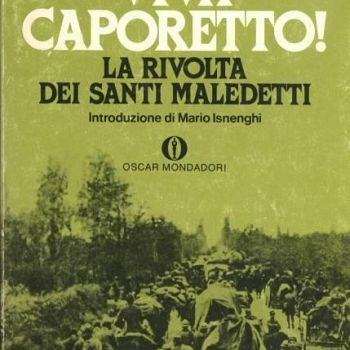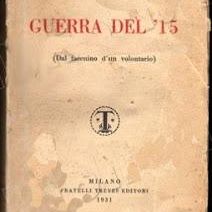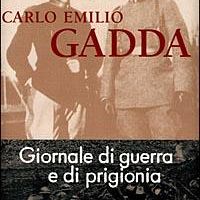ROMA - La letteratura di guerra racconta e interpreta uno degli argomenti più complessi e contraddittori della civiltà, la guerra, appunto, invenzione umana che racchiude gravi nefandezze accanto a episodi d’ineffabile eroismo; sono pagine che, oltre agli aspetti materiali dei combattimenti – morti, feriti, terrore, fango, pioggia, sole rovente, fame e malattie -, documentano il sentire sociale e politico di un popolo in guerra, le sue attitudini militari, il suo senso dello Stato, dell’onore e dell’attaccamento alla Bandiera.
Una letteratura che meriterebbe molto più spazio nell’insegnamento scolastico, perché specchio di sorprendentemente fedele di un Paese, soprattutto in epoche in cui la guerra rispondeva ancora al credo clausewitziano dell’onore, del rispetto del nemico e della Bandiera. La Prima Guerra Mondiale fu l’ultima ad essere combattuta secondo un’arte militare che il prosieguo del Novecento avrebbe poi quasi del tutto cancellata, e riscoprire a distanza di un secolo gli autori che sentirono l’urgenza di raccontarla, significa anche riassaporare un’etica oggi scomparsa.
Ma l’Italia, Paese dalle mille bellezze e dalle mille contraddizioni, visse in maniera ambigua anche quella che fu la fase conclusiva del suo Risorgimento. La mancanza di una cultura militare - direttamente collegata alla superficialità della cultura politica -, furono la causa dei grossolani errori commessi al momento dell’entrata in guerra nel 1915, e che si trascinarono per quasi tutta la durata del conflitto.
La letteratura italiana della Prima Guerra Mondiale è in buona parte la storia, dolorosa e assurda insieme, di quei malintesi che si creano fra politica e cittadini, e che ancora oggi viziano la normale vita sociale italiana. Molte di quelle pagine sono state scritte dai diretti protagonisti, perché tanti scrittori combatterono al fronte come volontari, ma dopo gli entusiasmi del “maggio radioso”, il nemico più grande da affrontare fu la disillusione.
Il triestino Giovanni Domenico (Giani) Stuparich (1891-1961), venne a contatto con l’interventismo a Firenze, dov’era studente universitario, e, disertando dalle file austro-ungariche, si arruolò volontario in quelle italiane del I Reggimento Granatieri di Sardegna. Raccontò la sua esperienza al fronte in Guerra del ’15 (dal taccuino di un volontario), sorta di diario che copre l’arco temporale dal 2 giugno all’8 agosto 1915, ovvero dall’arruolamento a Roma, fino alla seconda battaglia dell’Isonzo.
Fervente interventista che aveva combattuto a Firenze le stesse battaglie di Soffici e Papini, mal sopportava il clima d’ingessatura che si respirava nell’Esercito, per volere di Cadorna (che difettava anche in acume strategico). L’inerzia della vita di trincea, le lunghe attese prima di attacchi suicidi contro i reticolati nemici (puntualmente intatti, nonostante i cannoneggiamenti), furono le cause dell’insofferenza di Stuparich, che vide cadere le illusioni di maggio, e si scontrò con la realtà prosaica degli alti comandi.
Nelle sue pagine, l’autore ci lascia una rappresentazione impietosa, drammatica e realistica, lontana dalla propaganda cui era costretta la stampa nazionale. Nonostante queste gravi difficoltà, il coraggio dei soldati italiani al fronte non venne mai meno, e in condizioni del genere, se la cultura militare in Italia non ha mai allignato, la responsabilità è da attribuirsi alla cattiva politica, succube di comandanti incapaci, che misero in pessima luce l’Esercito agli occhi del Paese.
Quando invece i soldati italiani si battevano con onore e senso della responsabilità.
La letteratura di guerra, quella vera scevra di retorica, costituisce un settore dei più affascinanti nel mondo dell’editoria, grazie a scrittori la cui grandezza risiede, oltre che nell’abilità stilistica, anche e soprattutto nell’onestà intellettuale delle proprie idee, nel coraggio con cui le professarono, nei rischi che si sono assunti, nella coerenza con la quale hanno ricoperto il loro ruolo di soldati e di uomini con il senso dello Stato. Ne sono nate pagine intense, dalle quali spesso emerge l’anima messa a nudo dell’autore stesso, che dà voce a un’intera generazione, le cui certezze vacillarono una volta sperimentati i primi assalti, e che sovente si sentì, in un certo senso, tradita dalla generazione dei padri.
Una situazione materialmente e moralmente angosciosa, sulla quale ci restano, a distanza di un secolo, numerose testimonianze di alto valore letterario. Una delle più crude, è quel Giornale di guerra e di prigionia, scritto dall’ingegner Carlo Emilio Gadda, il quale è ben conscio del doppio ruolo di soldato e scrittore, e s’interroga sulle sue responsabilità nei confronti della società. Ecco che l’intellettuale diviene un alfiere della resistenza dell’uomo davanti all’orrore, nel suo commovente, eroico sforzo di cercare la bellezza anche nella tragedia, per evitare di perdere la sua dimensione umana. Pagine, quelle di Gadda, che cercano di trasferire la guerra su una dimensione più accettabile, aiutandosi, nel descrivere i combattimenti, con citazioni dall’Orlando, dal De bello gallico, dall’Eneide.
Su una linea meno pragmatica, si colloca Un anno sull’altipiano, di Emilio Lussu, la prima opera della letteratura italiana di guerra, a puntare il dito contro l’irrazionalità con la quale Cadorna la conduceva, e la durezza eccessiva della disciplina che applicava. Un tono accusatorio, quello di Lussu, il quale era stato fra gli interventisti più convinti. Ancora una volta, a minare il morale dei soldati, contribuiva quella commistione di cattiva politica e impreparazione strategica.
Non tutti la pensavano alla stessa maniera, e Ardengo Soffici fu tra questi. Partito anche’egli volontario, dopo che dalle pagine di Lacerba si era battuto per l’intervento, la sua missione al fronte consisté nel fungere da addetto allo Stato Maggiore della II Armata, e, dopo Caporetto, si occupò della propaganda al fronte, organizzando una serie di giornali di trincea quali La ghirba, e Signorsì. Della sua esperienza di combattente, peraltro limitata, ci restano le pagine di Kobilek, resoconto della battaglia per la presa dell’omonimo picco, nel corso della quale Soffici rimase ferito.
E ancora, dopo il famigerato 24 ottobre 1917, si trovò in mezzo alle colonne di sbandati, mentre cercava disperatamente di raggiungere il comandante della sua Armata. Poche pagine descrivono bene la rotta di Caporetto come La ritirata del Friuli, dove il disorientamento e la sfiducia sembrarono per un attimo prendere il sopravvento e condannare l’Italia alla sconfitta. Badoglio e Diaz riuscirono a riorganizzare l’Esercito, ma a Roma si comprese ben poco della portata morale che Caporetto doveva avere sul Paese, e non si presero i necessari provvedimenti sociali e politici.
Psicologicamente, quell’episodio lasciò tracce profonde nel soldato italiano, che vi lesse tutta l’impreparazione del Comando Supremo, e la mollezza del governo, sempre succube delle decisioni di Cadorna; serpeggiava quindi un malcontento che la Vittoria non riuscì a sopire, considerando sia la delusione cui l’Italia andò incontro circa le richieste territoriali avanzate a Versailles, sia la condizione di relativo abbandono cui furono lasciati i reduci, in particolare coloro che la guerra aveva reso invalidi. Un malcontento che fu terreno fertile per il Fascismo, che acutamente seppe scagliarlo contro le mancanze della democrazia giolittiana.
A intuire questo clima e le sue conseguenze, già nel 1917, fu soltanto uno: Curzio Malaparte. Volontario sulle Argonne con la Legione Garibaldina già nel 1914, combatté sul Col di Lana con l’Esercito Italiano, e ancora sul Fronte Occidentale, con la Brigata di Fanteria Alpi, in appoggio all’Esercito francese.
In un furioso stile “alfieriano”, urlato e polemico, Curzio Malaparte trae interessanti conclusioni su quelle che saranno le ripercussioni sociali della Grande Guerra, riflettendo sull’episodio di Caporetto e sulle deficienze degli alti comandi nel condurre la guerra e nel loro rapporto con le truppe. Quest’ultimo elemento in particolare, si ripercosse negativamente sull’Italia intera, favorendo quella mentalità di distacco del Paese dal suo Esercito, che troverà conseguenze nel disinteresse con cui verrà trattata la questione dei reduci. Malaparte lo ipotizza sin dall’inizio, e già immagina il disagio morale e materiale dei sopravvissuti alla trincea, e non sa intravedere per essi altro futuro che quello dei “rivoluzionari”, dei sovvertitori del sistema. Riflessioni suggeritegli anche dall’atteggiamento degli Arditi.
Pubblicato nel 1921, con il titolo di Viva Caporetto!, il saggio preconizzava l’avvento del Fascismo; censurato, uscì due anni dopo con il titolo La rivolta dei santi maledetti, forse ancora più emblematico. Malaparte aveva compreso il clima politico e le cause che portarono al Fascismo, ma come accade in Italia (il Paese delle cause e non degli effetti), nemmeno quella rivoluzione sociale si dimostrò capace di cambiare la mentalità del popolo italiano. E così, si uscì dal conflitto senza approfittare del clima euforico che la Vittoria aveva sulle prime creato, e si perse l’occasione di dare definitiva coesione al popolo italiano, e al contrario si favorirono malcontento e divisioni, delle quali ancora oggi paghiamo le conseguenze, e l’Esercito ne è forse la vittima più illustre.
Niccolò Lucarelli